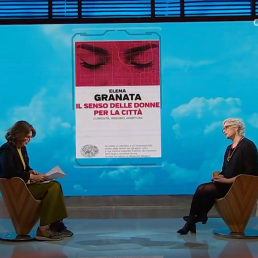Ci siamo dentro tutti in questo mare. E il naufragare non è affatto dolce
Ci siamo dentro tutti in questo mare. E il naufragare non è affatto dolce
E’ questo il Mediterraneo raccontato da Armin Greder (Orecchio Acerbo editore e Amnesty International, 2017): uno spazio dilatato e incerto che tiene insieme due sponde opposte, due mondi, le loro economie, le storie personali e collettive che in questo mare si confondono.
Una dolente meditazione di sole immagini.
Non è facile trovare le parole adeguate ad un libro così. Ma ci sarà un motivo per cui l’autore ha deciso che questa fosse la forma più adatta a raccontare quanto sta accadendo nel Mare Nostrum, forse perché ciascuno deve fare la fatica di capire, di pensare a quanto sta accadendo. Trovare le parole per l’indicibile, per quello che ci turba e ci disturba.
Una via Crucis in 17 stazioni
Inizia con un corpo molle, gravido di acqua, che dopo avere finito di annegare va verso il fondo del mare. E’ solo. Ha intorno solo acqua e silenzio e rumore del mare. Vestiti troppo larghi addosso e piedi senza scarpe. Finisce con una piccola imbarcazione colta nell’attimo esatto in cui smette di galleggiare e va a fondo: sopra un cielo che non ha più nulla da benedire, sotto un mare colore petrolio, increspato e mosso.
Un attimo. Poi tutto è compiuto.
Tra queste due immagini sta tutta la contraddizione del nostro tempo. Non ci resta che raccogliere i fili di questa storia nel mare. Anche io mi sottopongo, come gli altri lettori, a questo terribile esperimento di verità e attraverso gli occhi vedo, metto insieme, capisco, collego. La prima scena mi porta dritto a riflettere su quello che mangio. Non ci ho mai pensato.
Il corpo del ragazzo affogato – sono portata a pensarlo ragazzo, come i tanti ragazzi scampati ai naufragi del Mediterraneo che in questi anni sono passati da casa mia – diventa esso stesso cibo per i pesci che lo aspettano, avidi e affamati come solo la natura sa esserlo. Pesci pescati dalle reti dei pescatori, reti robuste, reti di chi sa come avere la meglio sulla natura. Pesci che poi troviamo al mercato del pesce, un girone dantesco di uomini sudati ed urlanti, di pesci svenduti alla sera, di folla che si accalca e finalmente, il pesce appare sulle nostre tavole, servito in un’osteria di mare.
Nella seconda scena due uomini sono seduti all’osteria e consumano il pesce e un patto scellerato. Hanno tratti marcati e decisi, uno è decisamente bianco, uno è decisamente nero. Intrattengono tra loro relazioni d’affari. Sono venditori di armi, a cui si accostano con la stessa naturalezza con cui mangiano, forse accarezzano i figli, si muovono per il mondo. Imbarcano le loro armi, nel viaggio che da nord va verso sud, su navi possenti, che non temono il mare, che solcano decise le onde, che sanno dove dirigersi, piene di armi e di morte. Non hanno bisogno di nascondersi, tutto avviene alla luce del sole, salpano dai porti di Sardegna e di Sicilia.
Sembrano così concordi e affiatati l’uomo bianco con la giacca e la cravatta, la testa calva e la parola pronta, che pensa di non sporcarsi le mani con la guerra e l’uomo dal vestito militare, il cappello calato sugli occhi, l’uomo che si sporca volentieri le mani con la guerra, che parla ai soldati con il carisma del capo, che li incita alla lotta.
La terza scena ci porta in guerra. In quella guerra che a noi urbani occidentali pare cosa d’altri tempi, da film in bianco e nero. Sono villaggi, bestiame in fuga, incendi nelle case e un esodo biblico di persone costrette alla fuga. Che cosa si portano via da quelle loro povere vite? I figli in braccio, i vecchi sulle spalle, qualche piccola valigia di fortuna. Si guardano indietro. La guerra non ha mai senso, non ha mai ragioni, non ha direzione. Se non l’istinto di andare più lontano possibile da quell’odore di morte e fuoco, di rovina e terrore.
Dov’è la frontiera?
Quante volte mi è stato raccontato in questi anni quello che è venuto dopo questa rovina. Sekou, scappato dalla Guinea a 15 anni ricorda solo di essere scappato all’improvviso. Da una vita normale, dalla mamma che lo aspettava la sera al ritorno dal lavoro, le voci di casa, la nonna, i fratelli. E’ partito per un viaggio che non ha scelto, cominciato all’improvviso, trovandosi in carovana tra i fuggitivi, senza potere più tornare indietro. Viaggio senza ritorno, destinazione ignota. Tappa obbligata il deserto, che è un tempo infinito, pieno di pericoli, di insidie e di predatori, di armi messe in mano ai bambini, di donne rapite, di amici che non ce la fanno più e restano indietro.
Buhari venuto dalla Nigeria non ricorda di avere avuto fame, né sete, né sonno. Quando scappi e sei nel fiore della vita non senti il corpo, senti solo la paura, quella paura che ti taglia le gambe e soffoca il respiro. Neppure il caldo tormenta quanto la paura. Quanto tempo ci vuole per attraversare il deserto del Niger? Quanto è grande la Libia? Quanto varrà la mia vita appena saranno finiti i soldi?
Per qualcuno l’attraversata dura qualche mese. Per altri qualche anno. Per altri ancora – troppi – non arriva alcuno sbocco sul mare. Perché non tutti hanno la forza, la resistenza, la fortuna di superare le molte frontiere di questo viaggio ad ostacoli, quello che ci ha raccontato Alessandro Leogrande nel suo libro La Frontiera (Feltrinelli, 2016), il libro più lucido e onesto e consapevole che la nostra generazione ha saputo immaginare sulle migrazioni.
Nella quarta scena tutto scorre rapido. Corpi accalcati su un camion nel deserto, un drappello di uomini, mercanti nel tempio, che discutono di soldi e di vite umane, una nave stracolma di persone si mette in viaggio nel mare. Non basta ascoltare i racconti di chi ha compiuto il viaggio, bisogna guardare la pelle, le piccole ferite sul corpo e sulle mani, le unghie che non sono ricresciute. Potrei riconoscere i miei ragazzi guardando i loro piccoli segni sul corpo. Chi è caduto dal camion, chi è stato strattonato salendo sulla nave, chi è scivolato correndo sulle spiagge della Libia, chi ha le ferite dei colpi sulla schiena, chi nasconde le ferite più profonde chissà dove. Quelle che non si possono raccontare. La folla, la calca, il caldo, l’odore acre dei corpi e della paura del mare.
Di tutte le paure quella del mare, per chi non l’ha mai visto, è quella più ancestrale. E’ una paura disperante, sono preghiere e canti incessanti, pronunciati a mezza voce, è il sole che cuoce la testa o l’odore di carburante che entra nella pelle.
Chiude il libro un naufragio
Tutto è stato vano. Il mare inghiotte i corpi e i loro sogni. Entro una sequenza terribile di eventi, torneranno i pesci, e il cibo sulla tavola, e le armi, e le guerre, e la fuga, e il mare.
“Il racconto di Armin Greder – scrive Leogrande nella postfazione al volume – recupera dal mare i tanti fili che legano quell’enorme cumulo di corpi privi di vita costantemente allontanato dal nostro sguardo, a noi, a tutti noi, alle nostre vite e alle nostre coscienze. A iniziare dai pesci che di quei corpi si cibano e che poi – a loro volta pescati – finiscono sulle nostre tavole”. L’autore ci porta sull’abisso e poi si congeda, non offre parole, né vie d’uscita, è narratore terribile, ci mette di fronte alla realtà, quasi senza giudizio.
Il viaggio dei superstiti possiamo immaginarlo noi. I controlli, le banchine assolate, le visite mediche, i centri di prima accoglienza, poi i pullman verso le destinazioni più impronunciabili, in Calabria, in Puglia, oppure al nord. Si capisce presto che il viaggio, il secondo viaggio, quello sulla terraferma verso una vita migliore è appena cominciato. Ci racconta di pomodori raccolti per pochi centesimi nelle campagne del sud, di latte che viene munto all’alba nelle stalle del nord. Se anche volessimo non potremmo chiamarci fuori. Quello che Armin Greder ci sta proponendo è un metodo, una forma di pensiero. Cominciare a pensare che nel tempo delle relazioni globali, tutto è connesso con tutto, quello che mangiamo, come ci vestiamo, le tecnologie che usiamo, il nostro conto in banca. Tutto ha a che fare con storie bellissime di innovazione e cambiamento e con enormi contraddizioni, abusi e sfruttamenti. Anche volendo, non potremmo sentirci innocenti, lontani da quanto sta accadendo, dalle storie ignote di chi ce la fa ad attraversare il Mediterraneo o di chi ne fa la propria tomba.
Guardiamo i segni sui corpi
Dobbiamo guardarli con più umanità questi uomini che sbarcano dalle navi sulle nostre coste. Guardare loro gli occhi, le mani, le labbra contratte. Ognuno è una storia, una madre che l’ha messo la mondo, fratelli rimasti lontani, canti nella testa, giorni di festa, sapori di cibo preparato a casa.
E c’è una storia nella storia. L’arrivo di bambini e ragazzi che emigrano da soli, senza genitori né parenti. Ne sono arrivati 25.000 nel 2016, 14.000 nel 2017. Arrivano dall’Egitto, dal Gambia, dalla Nigeria, dall’Eritrea. Sono sopravvissuti a pericoli, carcere, deserto, fame, violenze. Spesso hanno lasciato mamme e sorelle e fratelli e compagni di scuola. Sanno usare internet, si orientano con facilità, sono consapevoli di cosa hanno lasciato, non sapevano cosa avrebbero trovato. Di sera hanno nostalgia di casa, del loro cibo, degli amici. Quando hanno gli incubi sono soli, nessuno conosce le loro angosce più profonde. Hanno l’energia e la voglia di imparare dei ragazzi.
Non dovremmo più riuscire a dormire tranquilli nelle nostre case, nelle nostre chiese. Hanno bisogno di casa, di protezione, di un telefono per chiamare la mamma, di letti dove dormire, di madri e padri temporanei, disposti a condividere qualcosa con loro. Non possiamo delegare la loro crescita alle istituzioni, alle cooperative, ai servizi sociali, pur necessari. C’è bisogno di un movimento collettivo di madri e di padri disposti a lasciarsi scomodare, pronti ad aggiungere un letto in casa, almeno per dei periodi, un piatto a cena, una bicicletta in partenza per una vacanza.
C’è un istinto primordiale che ci rende umani, un istinto che ci accomuna agli animali, persino alle piante. Sentimento che ci spinge a prenderci cura di un altro essere umano, di farci carico della sua fragilità, delle sue paure, dei suoi sogni. Trascende la biologia, l’atto del mettere al mondo un figlio. E’ una tensione e un sentire dell’anima. Dobbiamo cominciare a ragionare di maternità fuori dai soliti schemi e dalle solite convenzioni (mamma-papà-figli). La sterilità del nostro Paese non sta nelle culle vuote, nelle coppie senza un progetto, nelle maternità ritardate ad oltranza, nella ricerca del figlio ad ogni costo. La sterilità è un’aridità dell’animo.
Con gli occhi di Alessandro
Il confine fra il mondo di qua e il mondo di là appare più incerto, osserva nella sua breve nota Alessandro Leogrande. Come a domandarsi: e allora noi dove siamo? Come ci pensiamo in questo tempo?
Avevamo sognato insieme, l’ultima volta che ci siamo visti a Milano, di chiamare a raccolta studiosi della nostra generazione che hanno provato a raccontare storie di migrazione. Non basta quello che stiamo facendo, dobbiamo fare di più, mi diceva. Lo diceva con quel suo fare mite e fermo insieme, di chi ha visto e sentito infinite storie di dolore e ha saputo trovare le parole per raccontarle. Ha dimostrato a tutti con la sua scrittura che si può essere giornalista rigoroso e partecipe narratore di storie di uomini e donne. Che c’è un dovere di capire, di mettere insieme i pezzi, di responsabilità da denunciare, di leggi, politiche e provvedimenti ingiusti da smascherare, quando violano i diritti umani e la dignità delle persone. Alessandro è morto a 40 anni in una domenica di novembre dello scorso anno. Rileggo come tanti amici le sue pagine preziose, un abisso di profondità, e continuo a ripetermi, come quel giorno, che noi non vediamo ancora abbastanza, non diciamo ancora abbastanza, non facciamo ancora abbastanza.
Mediterraneo
di Armin Greder
illustrazioni di Armin Greder
postfazione: Alessandro Leogrande
pubblicato anche in lingua inglese
area tematica: Raccontare il presente
luglio 2017