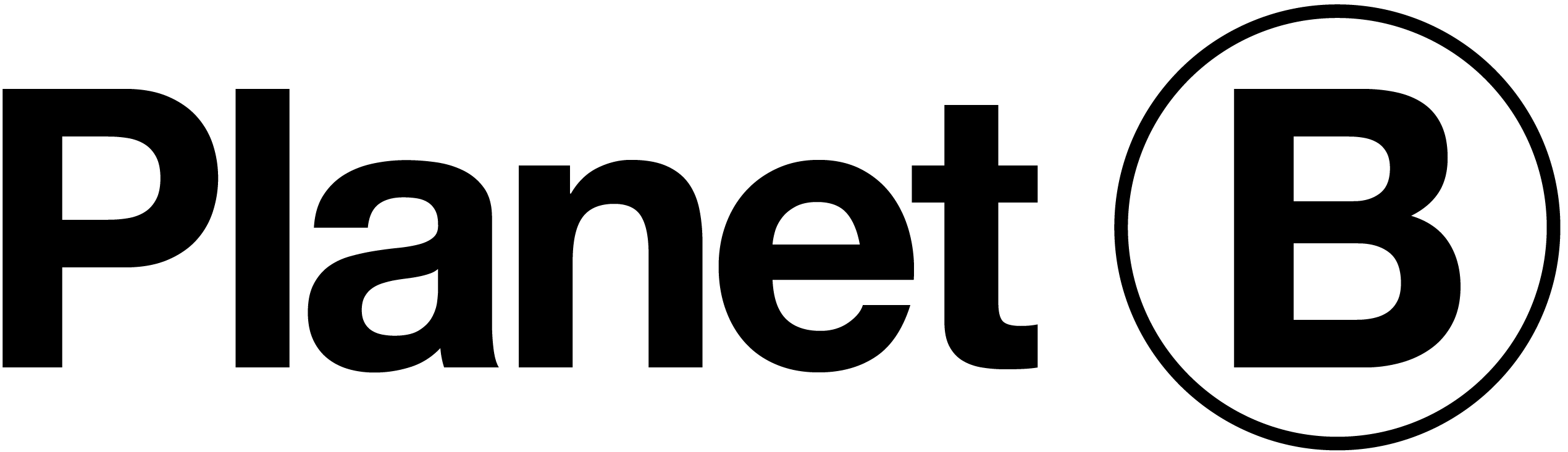Amazon o le cooperative di comunità: chi genera oggi lavoro nei territori?

Amazon o le cooperative di comunità: chi genera oggi lavoro nei territori?
Il lavoro e la città sono intrinsecamente legati.
Una città si fonda sul lavoro (il negotium, le attività legate al fare) e sull’effimero (l’otium, le attività legate al non fare). Quanto otium e negotium siano cruciali nella salute e nella vita di una città lo cogliamo quando i sistemi urbani vanno in crisi.
Quando un sistema economico collassa anche la città muore. Vanno in crisi i servizi, l’abitare, i sistemi pubblici. Ci sono esempi molto evidenti di questo collasso: una crisi che dal piano economico si allarga a quello sociale e ambientale.
Pensiamo alla città di Detroit, città d’elezione della Ford e di un sistema economico fondato sulla fabbrica, la cui forma urbana era stata pensata per ottimizzare la produzione industriale. Il ciclo produttivo dentro la fabbrica coincideva con l’organizzazione anche dei tempi e dei luoghi fuori dalla fabbrica. Un meccanismo perfetto che con la crisi industriale prima, quella finanziaria e immobiliare poi, ha mandato in crisi l’intero sistema urbano.
Nella nostra storia recente, dal dopoguerra, anche il nostro Paese ha conosciuto e sperimentato una serie di modelli di relazione tra città e lavoro. Ciascuno dei quali ha costituito anche un modello di sviluppo. La città fabbrica – i distretti – produzione edilizia e rendita.
Il lavoro scompare dalla scena urbana
Le città raccontano poco dei lavori che le tengono vive, spesso i lavori sono nascosti, il lavoro è immateriale. E’ il lavoro precario e sottopagato (l’Italia dei lavoretti, gig economy, Foodora, Uber) che fa di milioni di persone dettagli invisibili di un enorme ingranaggio di lavoro (pensiamo ad Amazon, al cibo a domicilio, alla telefonia). Sharing economy: sentimenti, condivisione, non sono ataviche forme di sopravvivenza nella disperazione?
A questa invisibilità si risponde spesso con dei palliativi, pensiamo al fenomeno del coworking, che è molto diffuso in città e ha come primo scopo quello di fare superare costi ma soprattutto solitudine e isolamento.
Non c’è più narrazione sul lavoro: non parlano i luoghi, non parlano le storie delle persone, non parlano le attività. E le nuove generazioni dove imparano la cultura del lavoro? Città delle reti e del terziario avanzato è la città che non mette più in scena il lavoro, tanto è vero che cerchiamo di riprodurlo in vitro come l’operazione Fico di Farinetti. I ragazzi non conoscono il lavoro e vanno a vederlo (stalle, cascine, fabbriche) e non li si conosce perché sono completamente nuovi.
Le risposte possibili sono di due tipi:
O si accetta il modello dello scambio asimmetrico (centri commerciali, multinazionali, logistica), che nasce dall’alto e da un attore predominante.
Quando il territorio diventa solo una piattaforma da sfruttare la localizzazione diventa un atto di arbitrio: pensate alla delocalizzazione delle aziende italiane all’estero, all’est, con il doppio effetto di lasciare scoperti e in crisi interi territori o comparti aziendali, andando a sfruttare comunità e territori con ancora meno diritti.
Esistono anche casi virtuosi, come modello Bilbao, di Frank Gehry, fondato su localizzazione di grandi funzioni attivatori di economie: università, centri di ricerca, musei, Modello Bilbao. O il Prosciuttificio di Preci.
Questioni aperte:
Cosa può fare la città intesa come amministrazione, come polis, come comunità civile?
Come attirare capitali, grandi funzioni esogene?
Come fa una piccola amministrazione a esercitare potere su imprese multinazionali?
Oggi è evidente che la politica possa poco rispetto all’economico, le grandi compagnie riescono persino a non pagare le tasse agli stati che li ospitano.
Ma qualche leva ce l’hanno: si tratta di immaginare un nuovo patto tra politica e società civile.
O si coltiva il modello della biodiversità che nasce dal basso e da molti attori.
(imprese di comunità – corridoi ecologici e territoriali – cibo e e turismo – forme della nuova agricoltura). Qui si profila un ruolo diverso per le amministrazioni locali, come catalizzatori, attivatori, generatori di opportunità, sugli spazi, le risorse – es. meccanismi premiali dentro i piani di governo del territorio, attivatore di processi di recupero di manufatti, la gestione della rete).




Elena Granata
Professore Associato di Urbanistica al Politecnico di Milano, docente alla SEC (Scuola di Economia Civile) e all’Istituto Universitario Sophia. Autrice di libri, saggi e articoli su riviste scientifiche e divulgative. Consulente di istituzioni pubbliche e private nel campo delle politiche urbane e culturali. Da anni si occupa di branding culturale e delle relazioni tra imprese e territorio. Co-founder di I’mpossible studio.