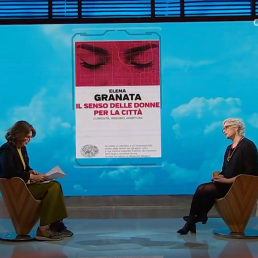Tutta colpa della scrivania? Come cambiano gli spazi del lavoro
Tutta colpa della scrivania? Come cambiano gli spazi del lavoro
La guerra è stata da tempo dichiarata.
Scrivanie, cassettiere, armadietti, spazi chiusi, ogni traccia residua di privacy sono state messe al bando, obsolete espressioni di un capitalismo che fu. La nuova frontiera dell’organizzazione del lavoro nelle grandi aziende multinazionali passa attraverso una radicale sovversione degli spazi. Da dove viene tanta improvvisa antipatia per le scrivanie?
In un primo momento si sono mossi i grandi brand americani del digitale, poi le aziende creative, infine anche banche, assicurazioni, sedi di grandi istituzioni. Hanno rimesso mano non solo ai loro spazi di rappresentanza ma anche agli uffici del personale, acclamando la trasformazione degli assetti fisici come la più grande rivoluzione dagli anni Sessanta.
I toni sono enfatici. La retorica decisamente convincente: siamo all’anno zero della trasformazione dei luoghi dove le persone lavorano, nulla sarà più come prima. La parola d’ordine sembra essere destrutturare.
Con uno strumentale e diffuso riferimento al sociologo Bauman e alla sua società liquida – peraltro molto ben criticata dal sociologo – si invocano spazi liquidi, per l’appunto, fluidi, dove le persone non sono costrette e vincolate ad una stessa postazione ma possano fluttuare nello spazio a seconda delle attività che devono svolgere durante la giornata. Uffici dove è possibile lavorare in qualsiasi spazio, in modo intercambiabile.
Il primo aspetto che viene in evidenza è il tono amichevole e confortevole che ammanta il nuovo assetto spaziale. Negli spazi di rappresentanza tutto è morbido, ovattato, colorato e giocoso. Piccoli animaletti appesi alle pareti, cuscini appoggiati a terra dove sdraiarsi gioiosamente, amache appese alle pareti ed enormi scivoli. Un’estetica da asilo nido o nursery da ospedale.
Bambinizzare gli spazi (anche) di rappresentanza è diventata l’ultima tendenza del design di interni. E per quanto fatichiamo davvero a immaginare seriosi manager in giacca e cravatta perdere ogni compostezza per rotolarsi tra i cuscini tra una delibera e l’altra, oggi lo smart work va proprio in questa direzione. Ha fatto scuola certamente l’esempio delle sedi internazionali di Google e Facebook che, tra i primi, hanno voluto trasformare i propri spazi di lavoro in manifesti di una ritrovata creatività e innovazione. Archiviati da tempo tavoli riunioni e uffici patinati, si progettano spazi in cui liberare la dimensione giocosa delle persone.
Il ripensamento degli spazi di lavoro si fonda sul presupposto che cambiando la natura degli spazi si possano modificare comportamenti e attitudini delle persone, improntandole a una maggiore informalità e creatività.
È quello che Carlo Ratti chiama il progetto della terza pelle (quella vera, i vestiti che indossiamo, lo spazio che ci avvolge), uno spazio che deve conformarsi alle esigenze delle persone e determinare il loro benessere, suggerendo emozioni, stati d’animo, comportamenti.
Questa estetica degli spazi di lavoro è funzionale al branding dell’azienda più che al benessere dei lavoratori. Le aziende più evolute sanno che gli spazi di rappresentanza e gli spazi virtuali riprodotti dai propri siti web, sono la prima attività di comunicazione che rivela al pubblico la natura dell’azienda e del prodotto. Così una comunicazione che si arricchisce di campi da basket, scivoli, biciclette, zone confort e relax e persino di stanze per la meditazione e lo yoga, offre un’immagine molto rassicurante del brand.
Ma dobbiamo scavalcare i cuscini e farci largo tra morbide poltrone per capire la vera semantica di questi spazi.
È questo il benessere aziendale di cui tanto si parla? Un confort messo in scena in forme raffinate e calde, rassicuranti e benevole.
Cosa induce a pensare che spazi destrutturati possano migliorare le relazioni umane e giovare alla governance dell’impresa?
Se tanto spazio viene dato alle relazioni informali dove viene nascosto – o si potrebbe dire relegato – il lavoro ordinario (fare una telefonata, scrivere una mail, fare due conti)? Se tutti giocano chi lavora?
Negli uffici tradizionali possiamo ancora rintracciare una marcata differenza tra scena e retroscena, tra funzioni di rappresentanza e spazi di lavoro ordinario dove dominavano spazi piccoli, serrati, angusti, a portata di voce. Fortemente connotati da separazione e privacy. Mutuando linguaggio e forme dal mondo teatrale, Goffman per primo ha provato a interpretare la vita al lavoro come una sorta di grande rappresentazione in cui si alternano spazi di ribalta e retroscena.
La ribalta è il luogo dove si svolge la rappresentazione, ed è fornito di un apposito corredo semantico (scena): qui vigono delle norme precise, che si possono distinguere in cortesia, modo in cui l’attore tratta il pubblico quando conversa con lui, sia con parole che con gesti, e decoro, modo in cui l’attore si comporta quando può essere visto oppure sentito dal pubblico. Le regole di decoro differiscono a seconda del contesto, e possono dar luogo a comportamenti particolari come nascondersi o far finta di lavorare.
Il retroscena di una rappresentazione si trova ai margini del luogo dello spettacolo; in genere è separato dalla scena da un divisorio, e costituisce per l’attore un riparo sicuro e un punto d’assistenza, dal momento che nessuno del pubblico può entrarvi. È il luogo dove si cala la maschera, si riprende energia, ci si concede la pausa dalle relazioni.
Particolarmente attenzione Goffman dedicava alle soglie, a quel delicato passaggio in l’attore passa dal retroscena alla scena (e viceversa), perché è il momento in cui si veste (o spoglia) di un particolare ruolo, e si possono cogliere le modificazioni – d’aspetto, di contegno, di atteggiamento – che caratterizzano le due diverse parti del territorio scenico.
L’analisi di Goffman, certamente datata, ancora ci aiuta a capire quanto gli spazi siano determinanti per i nostri comportamenti, determinano contegno e acquisizione di maschere comportamentali.
A volte siamo alla ricerca di collaborazioni e confronti, altre volte siamo alla ricerca di un luogo protetto dove distendere le gambe su una poltrona ed essere finalmente lasciati in pace. E considerando che la giornata media di un dipendente dura otto ore per un numero prolungato di anni, è impensabile pensare di trascorrerli sempre sulla ribalta, sotto gli occhi dei colleghi.
Ma così sta accadendo.
Negli spazi contemporanei è sancita l’assoluta indifferenza tra scena e retroscena. Tutto è scena e ribalta. Lo spazio dove le persone realmente lavorano si configura come un unico grande spazio aperto, senza fratture visive, senza separazioni, con pavimenti continui sgombrati da ogni possibile orpello e inciampo, con piccole stanze più raccolte destinate ai manager interamente trasparenti. Tutto visibile, tutto a vista, tutto perfettamente ordinato, tutto di tutti e nulla di nessuno.
Come in un perfetto set televisivo le persone arrivano al lavoro al mattino e viene loro assegnata una postazione e una mansione. Alla sera non devono lasciare traccia del loro passaggio. Come hanno trovato scrivanie sgombre al mattino, così debbono lasciarle alla sera, libere per accogliere qualcun altro la mattina successiva.
«Non abbiamo più delle scrivanie fisse. Arriviamo al mattino e ci sediamo dove capita, è rimasta solo una divisione per funzioni aziendali. Alla sera dobbiamo sgomberare tutto» raccontano in un’assicurazione nei nuovi grattacieli milanesi. Tutti possono sedersi dove vogliono all’interno del proprio piano. Il mondo del lavoratore viene miniaturizzato, ridotto ai locker, piccoli armadietti che contengono tutto quanto rinvia ad una vita fuori (il casco della moto, la borsa, un beauty).
Stupisce come questo assetto riesca ad essere tanto seduttivo e convincente. Chi può avere piacere a stare al lavoro come un nomade, senza punti di riferimento, senza relazioni di prossimità che si costruiscono nel tempo, intrecciando relazioni sempre diverse e senza che si possano consolidare relazioni di fiducia, abitudini e consuetudini condivise?
Le nuove fabbriche degli operai del digitale
Forse solo persone a cui viene chiesta una dedizione assoluta e una consacrazione alla causa riescono ad abitare luoghi senza volto.
Se, come dice Luigino Bruni, il capitalismo di questo tempo è una religione, questi spazi rendono evidente il culto e la abnegazione che viene chiesta ai suoi credenti. «Il nuovo capitalismo si è infatti accorto che senza attivare le motivazioni e i simboli più profondi dell’umano le persone non donano liberamente la loro parte migliore. Così chiedono molto, (quasi) tutto ai loro neo assunti, chiedono un impegno di tempo, priorità, passioni, emozioni, che non può essere giustificato ricorrendo al solo registro del contratto e del (pur molto) denaro».
La giovinezza è una componente fondamentale di questa operazione. «Nei primi tempi, e finché i lavoratori-dirigenti sono giovani, questo gioco di promesse, aspettative, restituzioni di riconoscimento e attenzioni reciproca Impresa-lavoratore funziona e produce una spirale crescente di impegno, risultati, gratificazione. Ma, col passare del tempo, questi investimenti affettivi e relazionali non riconosciuti si cumulano e diventano crediti emotivi, finché un giorno si capisce che non saranno mai saldati».
Più ci troviamo a discutere di benessere e in particolare di benessere legato agli spazi e all’organizzazione del lavoro, e più constatiamo come sia il malessere a condizionare la vita di tanti lavoratori.
L’incertezza e la paura di perdere il lavoro portano a comportamenti difensivi, per cui le persone non si espongono, non decidono e si rendono invisibili; talvolta si ammalano; lo stress riduce la performance lavorativa sia manuale che intellettuale ed aumenta il rischio di errori e di infortuni. Insicurezza, difesa dagli altri, scarsa affezione al posto di lavoro, poco coinvolgimento in attività comune, sono temi ricorrenti nelle storie di lavoro.
Una sofferenza spesso indicibile, reiterata nel tempo, poco condivisa persino con le proprie reti familiari e amicali. Perché la vita lavorativa sconta ancora molti tabù collettivi, insuccessi e frustrazioni, licenziamenti e mortificazioni trovano raramente forme di elaborazione collettiva.
La guerra alla scrivania ha un obiettivo economico evidente. Il riprogetto degli spazi punta soprattutto a ridurre le dispersioni nei costi: la flessibilità viene ottenuta nella forma più facile, sono le persone a muoversi nello spazio, a cambiare postazione, a aggregarsi sulla base di compiti e progetti. Meno lo spazio è rigido e più le persone saranno libere di muoversi, più lo spazio è contenuto e minori saranno i costi di gestione.
La necessità delle grandi aziende – dopo una stagione che le aveva localizzate fuori dai grandi contesti urbani – di tornare ad abitare spazi centrali e ben accessibili, aumenta naturalmente i costi di gestione e suggerisce alle aziende di “implodere”. Un’implosione che si traduce in una sintesi sottrattiva delle spese e degli spazi interni.
Si identificano location centrali, ben posizionate e ad alto valore simbolico e poi si lavora sugli spazi interni minimizzando al massimo i costi. Ridurre gli spazi ma soprattutto renderli utilizzati da tante persone nel corso della giornata, evitando più possibile momenti in cui restano inutilizzati, è una lima convincente per chi deve tenere sotto controllo spese e costi.
Si fa leva sullo spazio, che si contrae drasticamente e sul tempo, che viene ripensato e riorganizzato. L’open space (nato negli anni sessanta) è riproposto come una conquista, come l’assetto che può generare scambi positivi, collaborativi, socializzanti. Ma nessuno spazio di per sé è in grado di generare un certo tipo di comportamento. Si enfatizzano i vantaggi ma si eludono i disagi che spazi completamente privi di protezioni generano: distrazione, rumore, confusione, alienazione, difficoltà a concentrarsi.
Questo spazio indifferenziato e totalmente trasparente, totalmente privo di retroscena, in realtà configura qualcosa di molto simile alla fabbrica taylorista, dove gli operai, tutti fungibili, tutti riconducibili alla loro piccola mansione, erano ingranaggi di una sola macchina.
I nuovi operai del digitale, giovani, laureati, colti, ma in fondo tutti sostituibili e fungibili abitano uno spazio indifferenziato. Non devono essere riconoscibili, persino il talento può costituire un problema: sono solo mouse, tastiera e monitor, come un tempo era la catena in fabbrica.
L’operaio aveva tenaglia e martello, l’operaio digitale ha mouse e organi oculari al servizio di un monitor che lui pensa di gestire ma da cui è gestito. Ogni sua operazione lascia traccia, questa sì, nel monitoraggio del suo lavoro: pause, distrazioni, perdite di tempo, tempi morti, tutto.
Se lo spazio è sempre più ridotto, le persone in eccesso e precarie, l’introduzione del lavoro settimanale da casa è la soluzione perfetta.
Lo smart working è il primo e fondamentale strumento di riorganizzazione dei tempi di lavoro. Con una convergenza perfetta tra interesse aziendale e convenienza del lavoratore. È ovvio che per un lavoratore poter lavorare da casa in alcuni giorni del mese costituisce un indubbio vantaggio, riduce il numero di spostamenti casa lavoro, favorisce la conciliazione con le attività familiari, in taluni casi incide positivamente sul territorio. Ma non dimentichiamo che è innanzitutto un modo per ottimizzare i costi di gestione degli spazi, meno buoni pasto, niente straordinari, niente indennità di trasferta. Il cambiamento parte dalla formazione dei manager, poi investe l’organizzazione degli spazi, poi lavora sulle mense aziendali dove si pranza ma anche si lavora.
Nella sede Microsoft Italia di Milano ci sono 60 scrivanie su 100 dipendenti.
Il giovane manager risolva il problema matematico: quanti dipendenti dovranno stare in smart working per avere scrivanie per tutti? Con quale turnazione? Quali altri luoghi saranno utilizzati?
Dicono che i più giovani prediligono gradini e divanetti dove lavorare con il proprio pc. Che i manager sono felici di poter accompagnare i figli alle attività sportive durante la settimana. Che le giovani donne sono confortate dal poter trascorrere più tempo con i figli piccoli o in caso di figli disabili.
Eppure, un capitalismo dal volto così friendly dovrebbe indurci ad una certa cautela. Seduce e convince, premia e conforta, ma butta fuori dal sistema appena non si è più utili o vantaggiosi o competitivi.
In più il cambiamento è ammantato dalla retorica della partecipazione dei dipendenti. DEGW, studio di architetti che ha progettato la nuova sede Sky a Milano, è partita analizzando gli usi degli spazi in relazione alle modalità lavorative dell’azienda (circa 2300 dipendenti e 1000 tra consulenti e stagisti) riscontrando un utilizzo medio degli spazi chiusi pari al 40% del tempo trascorso in azienda. Oltre alla quantità ha rilevato anche la tipologia di utilizzo: di questo 40%, il 20% è dedicato ad attività individuali e l’altro 20% ad attività collaborative come riunioni e incontri operativi.
Nel nuovo progetto di uffici sono state quindi incrementate le sale meeting di piccola, media e grande metratura. «Lo spazio è stato dotato inoltre di touch down, spazi informali, quiet room e tutti quelle aree di supporto che favoriscono il business dell’azienda, permettendo anche l’incontro informale tra le persone». In una prima fase è stato realizzato e distribuito un questionario per capire le necessità delle persone e le performance degli spazi attuali. «Sono state incrementate le aree di supporto a disposizione di tutti: questo aumenta l’efficienza degli spazi e lo scambio di idee e conoscenze: le organizzazioni sono fluide, e lo spazio deve seguirle, se non precederle».
Uno spazio all’apparenza destrutturato è in realtà altrettanto normato, da altri rituali, burocrazie, sistemi di controllo. Non sono i muri a definire i comportamenti ma le regole, la prossemica, i movimenti nello spazio. Spazi spersonalizzati sono spazi adatti a figure precarie che oggi ci sono e domani forse no. E qui sta tutta l’ambivalenza delle grandi aziende: si chiede una consacrazione totale al dipendente, giovane, motivato e disposto a tutto; se ne rinforza la componente dipendente anche attraverso alcuni strumenti di welfare aziendale, che vengono caldamente consigliati, e sostituiscono i tradizionali premi economici (assicurazioni, servizi, sostegni); si cura particolarmente la comunicazione interna a rinforzo dell’identità e del senso di appartenenza; si trasmettono ai dipendenti una selezione di valori che dovrebbero essere condivisi (campagne per l’ambiente, i poveri, volontariato aziendale, sensibilizzazione ai temi della salute, del cibo).
Ma tutto questo “accade” in uno spazio più possibile anonimo.
Ancora una volta l’architettura diventa strumento di manipolazione. Presa dalle sue fascinazioni estetiche non si rende conto che è al servizio del nuovo capitalismo infelice (Bruni).
In fondo è sempre stato così nella storia. L’architettura è il primo strumento del potere, dei potenti, delle ideologie. Nessun altra disciplina riesce a plasmare i comportamenti e a suggerire ruoli, posizioni, valori.
Al lavoro non si lavora: il paradosso degli spazi di lavoro
È Jason Fried, autore del libro Rework. Manifesto del nuovo imprenditore minimalista (2010), ad avere raccontato con ironia l’idea assurda di una società che costruisce luoghi dove le persone vanno per lavorare già sapendo che in quei luoghi non riusciranno a farlo. “Quando chiedo alla gente – e sono dieci anni che faccio loro questa domanda: “Dove andate quando dovete lavorare su qualcosa?” sento risposte tipo: “La veranda, la terrazza, la cucina”. Sento risposte tipo: “La stanza in più che abbiamo a casa, il seminterrato, la caffetteria, la biblioteca. Vi sentirete dire: Il treno, l’aereo, l’auto. Il tragitto casa-lavoro. E sentirete persone rispondere: “Non ha importanza dove sono, basta che sia molto presto al mattino o molto tardi la sera, o nei weekend”. Quasi nessuno vi dirà: l’ufficio. Ma le aziende spendono tutto questo denaro in posti chiamati uffici, fanno in modo che le persone ci vadano, eppure la gente non ci lavora” (Jason Fried, Come mai non si lavora al lavoro, TED Talk, 2010).
Perché per lavorare abbiamo bisogno di tempi di pace prolungati. Conta il fattore tempo, oltre allo spazio. Molte poche persone hanno veramente lunghi periodi di tempo senza interruzioni in ufficio. Per questo le persone scelgono di lavorare da casa, o vanno in ufficio ma ci vanno la mattina molto presto, o la sera tardi, quando non c’è nessuno, o si fermano dopo che tutti sono andati, o ci vanno nei weekend, o lavorano in aereo, o lavorano in auto o in treno perché lì non ci sono distrazioni.
Quindi facciamo il punto. Le migliori aziende si dotano di splendidi spazi di rappresentanza, colorati e giocosi, mentre la maggior parte dei lavoratori condivide spazi angusti e affollati in cui inventa tempi e modalità di sopravvivenza per poter lavorare, nonostante l’inadeguatezza del modo in cui sono stati organizzati. Per rispondere alle norme sociali, talvolta arriva a fingere di lavorare nelle ore d’ufficio, per concedersi poi tempi di recupero del lavoro nelle sere, al mattino presto o nei fine settimana. Più il lavoro è immateriale e poco legato ad un fare pratico e più questa dissociazione tra tempo, spazi e attività si accentua. Con esiti talvolta grotteschi, talvolta dannosi per la produttività stessa dell’azienda.
Prendersi cura di spazi e persone
Per questo è fondamentale ragionare sulla natura e sulla qualità degli spazi spazi, che rendono possibile lavorare, lavorare bene o non lavorare affatto. L’organizzazione degli spazi di lavoro incide sulla qualità della vita al lavoro, sulle relazioni, sulla produttività, sulla salute.
Si tratta di partire dalla consapevolezza che la presa in cura dello spazio di lavoro e delle relazioni che vi si generano (così come dei territori in cui queste avvengono) è parte dell’attenzione al risultato del lavoro e influisce direttamente sulla produttività e sulla qualità del prodotto. Ma spazi e esigenze reali delle persone non possono essere dissociate.
Siamo sensibili al caldo e al freddo, alla luce e al buio, alle aperture e alle chiusure, ai materiali, alla distanza o vicinanza con gli oggetti (prossemica) e con gli altri, al confort e benessere che gli oggetti suscitano in noi (ergonomia).
Abbiamo una “giusta misura” che incide sul nostro benessere e che va progettata. Spazi chiusi o aperti? Spazi rigidi e sempre uguali o modificabili? Ad ognuno la sua postazione o posizioni interscambiabili? Certamente oggi una certa apertura, ambiguità e flessibilità degli spazi favorisce il benessere delle persone, evita rituali rigidi e abitudini comportamentali troppo rigidi. Queste qualità possono favorire relazioni sociali produttive, fiducia e collaborazione, generare creatività e aspirazione alla qualità. Ma questa relazione è una scommessa, una responsabilità che accoglie la libertà delle persone, la loro voglia di mettersi in gioco.
Esiste un’alternativa agli open space imperanti?
Non esiste la ricetta perfetta ma certamente ogni contesto può avere un proprio imprinting, una propria sintesi tra spazi, valori, vita delle persone. Perché ogni luogo di lavoro è denso di significati e implicazioni che agiscono su coloro che li abitano. Influisce sulla vita di chi lavora, sul prodotto, sulla reputazione dell’impresa (branding). Incrementa il capitale umano, stimola impegno, senso di appartenenza, produttività.
Esista una forte correlazione tra ambiente di lavoro e luogo di relazioni (habitat) e delle persone, le loro abitudini, la loro attitudine a collaborare (habitus). Lo spazio è, infatti, determinante fondamentale dell’essere: concorre alla crescita delle persone e al loro sviluppo cognitivo, può accrescere le loro capacità e il loro benessere quotidiano, così come può diventare limite e impedimento. C’è una relazione biunivoca tra luogo e persone, i luoghi incidono sulla vita delle persone ma le persone plasmano e modellano i luoghi con i loro comportamenti, là dove sia possibile e dove vengano concessi loro spazi di intervento e coinvolgimento attivo.
Come scriveva Richard Sennet nel suo L’uomo artigiano (Feltrinelli, 2013), non è il lusso o l’apparenza dello spazio a valorizzare la qualità del lavoro, conta il corpo, le prossimità, le distanze, la possibilità di parlarsi, di sentirsi a proprio agio, la luce e l’aria.
Progettare “spazi per pensare e agire insieme”
E forse, se vogliamo essere ancora più radicali, non possiamo neppure pensare solo alle esigenze personali e individuali, ci sono alcuni valori collettivi e civili che possiamo tornare a coltivare nello spazio del lavoro. Così come un tempo è stato nelle fabbriche, straordinari luoghi di fatica, di produzione ma anche di partecipazione politica e civile.
Il lavoro, scrive sempre Sennet (Insieme. Rituali, piaceri, politiche della collaborazione, Feltrinelli, 2014) può instillare nelle persone un comportamento sociale di tipo dialogico e collaborativo. Collaborare è un’attività creativa che si serve dei deboli e dei forti, perché non dimentica il senso e l’obiettivo del proprio agire. È capacità di dialogare, di leggere dietro le parole degli altri. Richiede di usare il condizionale, di non essere sempre e solo assertivi, di guardare l’altro con empatia e non solo con simpatia.
Ce lo ha spiegato Yves Morieux, direttore del Boston Consulting Group’s Institute for Organization, grande esperto di processi collettivi, con l’immagine sportiva della staffetta: nella gara non vince la squadra che ha i giocatori migliori, i più veloci, i più scattanti. Vince la squadra con la migliore sincronia e sintonia di gruppo. Dunque paradossalmente anche la più lenta. La vittoria di una squadra non è determinata dalla somma di segmenti spazio-temporali, tutti perfetti ed omogenei. Dipende da quell’imponderabile energia che si sprigiona nella collaborazione tra i singoli corridori. Grazie alla collaborazione, l’intero vale più della somma delle parti. Sta tutto qui il potenziale degli sforzi umani: consentire alle persone di ottenere insieme quello che da soli non potrebbero mai raggiungere. Ogni attività sociale e collettiva funziona come una corsa a staffetta. Così in politica, nella ricerca, nell’economia. Così nella gestione di un’azienda o nella organizzazione di una scuola. È la capacità di collaborare che può fare la differenza tra un sistema vincente e uno a scartamento ridotto (Steven Sloman, Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza. Perché non pensiamo mai da soli, Cortina, 2018). Progettare spazi che aumentino il benessere individuale significa certamente fare attenzione alla luce e al calore di una stanza, ma soprattutto domandarsi come accrescere la maestria e creatività delle persone, suscitare comportamenti collaborativi e cooperativi. Se a prendersi cura degli spazi non fossero solo manager e architetti ma anche le persone che in quei luoghi staranno per ore e ore, spesso per anni, tutto potrebbe risultare più facile.